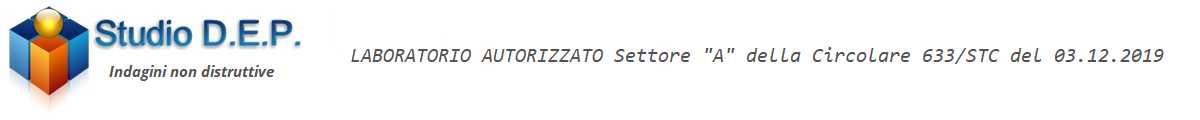FerriniDEP
La valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti
Quando parliamo di valutazione della vulnerabilità sismica è fondamentale fare una riflessione su tale aspetto soprattutto per quanto concerne gli edifici esistenti (scuole, ospedali, edifici per civile abitazione, ecc…) in riferimento al cap. 8 delle NTC (D.M. 14/01/2008).
Un aspetto significativo è che per effetto del sisma, hanno subito danno più o meno rilevanti anche edifici relativamente recenti e non progettati per resistere a soli carichi verticali o con procedimenti di calcolo approssimati, facendo emergere molteplici aspetti di ordine esecutivo rispetto a quello progettato per esempio: la non corretta piegatura delle estremità delle staffe nei pilastri, l’insufficiente armatura nei nodi non interamente confinati, l’insufficiente armatura a taglio di pilastri normali e di quelli tozzi o resi tozzi, l’insufficiente ancoraggio delle armature longitudinali delle travi, la non conformità del calcestruzzo impiegato rispetto alle previsioni progettuali.
La manifestazione ripetitiva dei danni strutturali è la dimostrazione che alcuni difetti esecutivi delle strutture in c.a. sembrano rispettare delle vere e proprie regole costruttive; a tal fine è consigliabile che i disegni originali di carpenteria siano sempre verificati con il costruito.
Le norme tecniche al cap. 8 integrato con la Circolare Ministeriale n.617/2009 danno precise indicazioni sui criteri da adottare per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti; individuati da diversi livelli di conoscenza da adottare (LC1, LC2, LC3) per acquisire informazioni sulla geometria, dettagli costruttivi e proprietà dei materiali in base al tipo di analisi strutturale globale e dei valori dei fattori di confidenza. Le indagini sono fondamentali per il tecnico incaricato al fine di poter esprimere un giudizio e poter predisporre gli eventuali interventi di consolidamento o di adeguamento necessari soprattutto per pilastri, travi e nodi non interamente confinati.
Di importanza rilevante risulta l’interpretazione delle prove distruttive e non distruttive per la stima delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo o meglio dei calcestruzzi posti in opera ai fini della verifica globale.
Il paragrafo 8.1 delle NTC definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura portante completamente realizzata, quindi anche costruzioni recenti.
Uno studio del Censis del 1999 ha individuato due categorie principali di vulnerabilità fisica degli edifici esistenti:
- degrado per vetustà (dipendente dal periodo di costruzione);
- degrado per ragioni costruttive ( dipendente dalla modalità di costruzione).
Per edifici in c.a. aventi più di 40 anni di vita i controlli sulle strutture e gli interventi di manutenzione si rendono necessari per prevenire ed evitare crolli e dissesti. Ci si trova sovente a dover operare su edifici costruiti dagli anni ’50 del secolo scorso fino ai giorni nostri, con norme tecniche via via sempre più complesse, escluse le opere abusive.
Una particolare attenzione va posta agli edifici costruiti durante il cosiddetto “boom edilizio” della fine degli anni ’60 in quanto caratterizzati da esecuzioni poco controllate e quindi con alte probabilità di impiego di materiali strutturali di qualità e resistenza a volte discutibili.
La C.M. 617/09 chiarisce che il problema della sicurezza delle costruzioni esistenti è di fondamentale importanza in Italia, da un lato per l’elevata vulnerabilità, soprattutto rispetto alle azioni sismiche, dall’altro per il valore storico-architettonico-artistico-ambientale di gran parte del patrimonio edilizio esistente. A ciò si aggiunge la notevole varietà di tipologie e sub-tipologie strutturali, quali ad esempio nell’ambito delle strutture murarie, quelle che scaturiscono dalle diversificazioni delle caratteristiche dell’apparecchio murario e degli orizzontamenti, e dalla presenza di catene, tiranti e altri dispositivi di collegamento.
La C.M. n.617/09 ripropone i concetti di livello di conoscenza (relativo a geometria, dettagli costruttivi e materiali) e di fattore di confidenza che modificano i parametri di capacità in ragione del livello di conoscenza.
In pratica per eseguire la verifica sismica globale o locale di un edificio esistente è opportuno raccogliere precise informazioni sulle strutture in elevazione e in fondazione, ai fini di una loro approfondita identificazione e in particolare acquisire dati relativi a:
- Livello di degrado del calcestruzzo delle armature;
- Resistenza a compressione attuale del calcestruzzo in opera o meglio delle diverse miscele impiegate, stimate con indagini distruttive e non distruttive o metodi combinati;
- Caratteristiche geometriche (diametro, superficie liscia o ad aderenza migliorata) e meccaniche (tensione di snervamento, tensione di rottura) dell’acciaio per c.a. impiegato;
-
Dettagli costruttivi degli elementi strutturali in elevazione e in fondazione, in particolare:
- Armature delle travi e dei pilastri;
- Armatura dei nodi trave-pilastro, soprattutto per i nodi non interamente confinati;
- Armature delle solette rampanti/travi a ginocchio delle scale;
- Ancoraggio delle estremità delle armature, specialmente se è stato impiegato ferro liscio;
- Comportamento a flessione di alcuni elementi strutturali (travi, solai e sbalzi) mediante l’esecuzione di prove di carico;
- Rilievo degli eventuali danneggiamenti subiti dalle strutture per diverse cause (eccesso di carichi verticali di servizio, scosse sismiche, incendi in appartamenti, perdita di liquami dalle colonne di scarico, materiali corrosivi, degrado in generale, ecc…)
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su costruzioni esistenti devono tener conto dei seguenti aspetti, in parte già evidenziati dall’O.P.C.M. n.3274/2003, ora trasfusa nelle NTC e nella Circolare n.617/09:
- la costruzione deve riflettere lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
- possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e realizzazione;
- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano completamente manifesti;
- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria.
Nella definizione dei modelli strutturali si dovrà, inoltre, tenere conto che:
- la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipende solo dalla documentazione disponibile e dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive;
- la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze legate alla produzione e posa in opera ma solo della omogeneità dei materiali stessi all’interno della costruzione, del livello di approfondimento delle indagini conoscitive e dell’affidabilità delle stesse;
- i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza dipende dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive.
Si dovrà prevedere l’impiego di metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione disponibile e l’uso, nelle verifiche di sicurezza, di adeguati ”fattori di confidenza”, che modificano i parametri di capacità in funzione del livello di conoscenza relativo a geometria, dettagli costruttive e materiali.
Il paragrafo C8.3 della C.M. n. 617/09 chiarisce che per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a :
- Stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle norme tecniche, oppure
- Determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, come definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.
La C.M. n. 617/09 evidenzia che la valutazione della sicurezza di un edificio dovrà effettuarsi ogni qualvolta si eseguono interventi strutturali e si dovrà determinare il livello di sicurezza della costruzione prima e dopo l’intervento che può essere di adeguamento, di miglioramento e di riparazione.
Il progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza già presenti e quelli raggiunti con l’intervento strutturale, nonché le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione. Tale aspetto richiede l’esecuzione di indagini in opera in quanto il progettista dovrà necessariamente supportare le proprie determinazioni sulla valutazione della sicurezza dell’edificio oggetto di analisi.
La valutazione della sicurezza per gli edifici esistenti potrà essere eseguita con riferimento ai soli stati limite ultimi.
Un’utile guida possono essere le “Linee di indirizzo per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ai sensi del DM 14 gennaio 2008 e della circolare n. 617/2009” contenuta nella Deliberazione n. 1168 del 26/07/2010 della Regione Marche.
Gli esiti delle verifiche di sicurezza dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinchè l’uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC.
Per i beni tutelati, la C.M. n.617/09 evidenzia che gli interventi di miglioramento devono essere in linea di principio in grado di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza, ferma restando la necessità di valutare quest’ultima.
Per la stessa ragione, su tali beni devono essere evitati interventi che insieme li alterino in modo evidente e che richiedano l’esecuzione di prove invasive o l’attribuzione di destinazioni d’uso particolarmente gravose.
Testi consigliati:
- Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti in cemento armato – S. Lombardo – Dario Flaccovio Editore;
- Verifica sismica di edifici esistenti in muratura – S. Podestà – Dario Flaccovio Editore;
- Il controllo strutturale degli edifici in cemento armato e muratura – S. Bufarini, V. D’Aria, R. Giacchetti – EPC Libri
Le prove di carico sono contemplate al § 9.2 del D.M. 14 gennaio 2008 e sono previste dal Collaudatore allo scopo di certificare la sicurezza dell'opera. Della loro concreta attuazione è responsabile il Direttore dei Lavori, che deve essere informato sul programma delle prove da eseguire unitamente al Progettista dell'opera da collaudare. Le prove di carico non devono essere svolte prima che sia stata raggiunta la resistenza del conglomerato prevista e in nessun caso prima di 28 giorni dall'ultimazione del getto.
Gli impalcati civili sono generalmente costituiti da solai realizzati con travetti paralleli poggiati su travi impostate su pilastri.
La continuità degli elementi orizzontali, travetti dei solai e travi, comportano una collaborazione delle varie strutture con un trasferimento di sollecitazioni dalle zone sottoposte direttamente ai carichi a quelle scariche. Anche il legame trasversale dei vari elementi paralleli, costituito dalla soletta superiore, produce un modello statico di piastra, diverso da quello più gravoso generalmente adottato in fase di progettazione di travetti indipendenti per cui ognuno assorbe per intero tutto il carico su di esso gravante.
La normativa vigente prescrive che in fase di collaudo le condizioni di carico da realizzare devono produrre le massime sollecitazioni di esercizio (in combinazione rara) ottenute durante la progettazione e la realizzazione di quanto prescritto pone la necessità di studiare l'impalcato con riferimento alla continuità trasversale e longitudinale.
Per avere un esito positivo delle prove devono verificarsi le seguenti condizioni:
- sviluppo delle deformazioni proporzionale ai carichi imposti;
- assenza di lesioni, deformazioni o dissesti che compromettano la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- entità della deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico.
Nel caso in cui tale limite venga superato, si rende necessario effettuare ulteriori prove di carico atte ad accertare che la struttura tende ad un comportamento elastico.
La conseguenza relativa alla collaborazione trasversale, sempre trascurata in fase di verifica teorica, è di difficile ed incerta definizione per l'impossibilità di definire i vincoli trasversali della piastra in esame. È possibile utilizzare curve di tipo statistico che possono essere verificate mediante i risultati della prova di carico.
IL CARICO
La maggior difficoltà che si incontra nella esecuzione delle prove di carico è l'approvvigionamento del carico necessario, specialmente se le prove vengono effettuate quando il cantiere è in fase di smobilitazione o a chiusura lavori. I materiali utilizzati per realizzare il carico di prova possono essere i più svariati: sacchi di cemento, pedane di mattoni, materiale sfuso, ecc... L'utilizzo di materiale sfuso ha l'inconveniente della difficile determinazione del peso specifico apparente quando è disposto come carico. Tali inconvenienti si eliminano adoperando contenitori, leggeri e di facile trasporto da riempire di acqua. In tal modo si realizza un carico di valore ben determinato che varia gradualmente ed uniformemente senza l'intervento di manodopera e che è possibile lasciare anche per lunghi periodi di tempo senza temere l'azione degli agenti atmosferici in relazione ad un aumento di carico difficilmente valutabile, come può avvenire per i materiali sfusi.
Sono attualmente disponibili sul mercato materassi di materiale plastico, contenitori circolari di plastica di forma tronco conica di capacità pari a 100 litri che è possibile mettere in serie per raggiungere il carico di prova. In alternativa è possibile realizzare delle vasche da riempire successivamente impermeabilizzate con fogli di plastica (per carichi < 500 daN/mq).

GLI STRUMENTI DI MISURA
La determinazione degli spostamenti verticali viene eseguita con apparecchi di misura con sensibilità sufficiente a rilevare con precisione i valori incogniti. Negli edifici residenziali gli spostamenti massimi sono generalmente inferiori al millimetro, mentre i residui allo scarico possono essere anche inferiori al decimo di millimetro; si rende pertanto necessario l'uso di comparatori centesimali con quadrante di un centimetro. Nei fabbricati industriali, invece per effetto delle notevoli dimensioni delle luci dei vari orizzontamenti, gli spostamenti prodotti dai carichi applicati sono generalmente più ampi e possono raggiungere anche vari centimetri.
|
Comparatori analogici o digitali: Lo strumento basa il suo funzionamento sulla lettura dello spostamento di un'asta cilindrica mobile che scorre all'interno di una guida tubolare. L'estremità dell'asta (chiamata tastatore o palpatore) è a contatto con la superficie dell'oggetto sottoposto a misura. Una molla spinge costantemente l'asta verso l'esterno del corpo del comparatore, assicurando così che il tastatore sia perennemente in contatto con l'oggetto di misura. Quando la superficie si sposta nella direzione dell'asse dell'asta (avvicinandosi o allontanandosi), anche quest'ultima si muove. Un sistema di lettura amplifica e visualizza questo spostamento rendendo disponibile la misura.
Catena di misura formata da : |
 |
- centralina di acquisizione dati costituita da un Data Logger a microprocessore compatto per monitoraggi a medio e lungo termine, i cui dati possono essere scaricati localmente; risoluzione: 24 bit; campionamento: da 6.8 Hz a 3.5 KHz;
- trasduttori lineari di spostamento con tastatore, sensore senza contatti, corsa da 30- 50 mm, risoluzione: 1/100 di mm, dotati di cavo di connessione sensori e stativi sensori estendibili da 1.80 a 6.00 mt.
Ulteriore tecnica valida per qualsiasi valore dello spostamento verticale è la livellazione condotta con livelli di precisione o con l'utilizzo di stazioni totali che permettono la lettura del decimo e la stima del centesimo di millimetro e non ha alcuna limitazione sull'entità dello spostamento massimo.
NORMA DI RIFERIMENTO:
D.M. 14 Gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni)
Principi di funzionamento
I martinetti piatti singolo e doppio rientrano nella tipologia delle prove non distruttive in quanto causano un limitato danno al materiale, circoscritto all’area di prova, facilmente ripristinabile al termine della stessa.
L’impiego dei martinetti piatti per la valutazione in situ delle caratteristiche meccaniche
delle murature consente:
• il rilievo delle tensioni attuali d’esercizio;
• il rilievo delle caratteristiche di deformazione.
Lo stato di tensione attuale d’esercizio e le caratteristiche di deformazione (modulo di elasticità normale e modulo di Poisson) di murature costituite da elementi resistenti artificiali (laterizio) e naturali (pietra) con marcate eterogeneità possono essere valutate in situ, con l’impiego, rispettivamente, di martinetto piatto in configurazione singolo e doppio, introdotti in una discontinuità orizzontale (giunto di malta) dell’elemento strutturale.
L’impiego della tecnica con martinetti piatti viene dichiaratamente menzionata nella Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni” al punto C8A (appendice al Cap. C8) – C8A.1 “Stima dei livelli di conoscenza e dei fattori di confidenza” – C8A.1.A.3 “Costruzioni in muratura: proprietà dei materiali”.
L’impiego del martinetto piatto singolo consente la valutazione dello stato di sollecitazione locale.
Tale valutazione è basata sul rilascio delle tensioni misurando le deformazioni conseguenti all’annullarsi della sollecitazione presente in una zona della muratura.
L’impiego di due martinetti piatti (martinetto piatto doppio) permette la delimitazione di un campione di muratura di dimensioni apprezzabili da sottoporre a sollecitazione monoassiale. La prova consente, attraverso la contemporanea misura delle deformazioni e delle pressioni esercitate dai martinetti piatti al campione di muratura, di determinare il valore del modulo di deformabilità per diversi livelli di sollecitazione. Il carico applicato alla muratura dai due martinetti piatti può essere progressivamente incrementato sino al manifestarsi delle prime lesioni, in modo da determinare la resistenza a compressione.
Ambiti di indagine
- Valutazione dello stato di sollecitazione locale
- Determinazione del valore del modulo di deformabilità e del modulo di Poisson
Prove correlabili
- Endoscopia per ispezione visiva di cavità, eventualmente presenti e/o risultanti da carotaggio
- Prove soniche
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ASTM International C1196-09 “Standard test method for in situ compressive stress within solid unit masonry estimated using the flatjack method”;
- ASTM International C1197-09 “Standard test method for in situ measurement of masonry deformability properties using the flatjack method”.
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
- Pompa idraulica manuale a due manometri M2H16 GLOTZL
- Deformometro millesimale con comparatore MITUTOYO e barra di taratura in acciaio RIGOR da 250 mm

Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 - “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”
Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 – “Acciaio, altre parti ed allegati”
O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274
- Allegato 1 - Criteri per l'individuazione delle zone
- Allegato 2 - Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici
- Allegato 3 - Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti
- Allegato 4 -Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione ed il sostegno dei terreni
- Documento esplicativo
O.P.C.M. 2 ottobre 2003, n. 3316- “Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»”
O. P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431- Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».
Norme tecniche per le costruzioni: D.M. 14/01/2008
Circolare esplicativa NTC-2008 del 2 febbraio 2009 n.617
ROCCO FERRINI
- Ingegnere Edile-Architetto, laureato presso il Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura nel 2008, con voto 103/110.
- Ha svolto una tesi di laurea in “Recupero e conservazione degli edifici” dal titolo “ Il recupero del patrimonio edilizio sanitario storico: il caso del Policlinico di Bari”.
- Specializzato in controlli e diagnostica non distruttiva nelle costruzioni in cemento armato e muratura, ha conseguito il titolo di “NON-DESTRUCTIVE TESTING MANAGER - Civil Engineering” riconosciuto dall’università ROMA TRE e dall’istituto INFORMA.
- Qualificato come Tecnico specializzato di III^ livello dal Bureau Veritas in controlli non distruttivi delle strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato precompresso conformemente a quanto previsto dalla ISO 9712:2012.
- Qualificato come Tecnico specializzato di II^ livello dal Bureau Veritas in prove di carico statiche su solai, impalcati, ponti e viadotti, prova termografica e monitoraggio delle strutture conformemente a quanto previsto dalla ISO 9712:2012.
- Iscritto all’Associazione MASTER come tecnico certificato PND
- SOCIO FONDATORE e Consigliere Nazionale dal 2018 dell’Associazione CODIS (Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali).
CERTIFICAZIONI
Settore CIVILE
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Metodo Magnetometrico (MG)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Metodo Sclerometrico (SC)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Metodo Ultrasonoro (UT)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Monitoraggi strutturali di quadri fessurativi (MO)
- Certificazione di livello 2 operatore CND – Prove di carico statiche su solai, impalcati, ponti e viadotti (PC)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Prove termografiche (TT Civ)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Analisi delle strutture in muratura mediante la tecnica dei martinetti piatti (MP)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Esame visivo delle opere (VT)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – prova di penetrazione su calcestruzzo/malta/legno (PE)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – prova di estrazione pull out/pull off (ES)
- Certificazione di livello 3 operatore CND – Prelievo di campioni e chimiche in sito (CH)
Settore INDUSTRIALE
- Certificazione di livello 2 operatore CND – Metodo Magnetoscopico (MT)
- Certificazione di livello 2 operatore CND – Metodo Liquidi Penetranti (PT)
- Certificazione di livello 2 operatore CND – Metodo Visivo (VT)
- Certificazione di livello 2 operatore CND – Metodo Ultrasonoro (UT)
 |
 |
 |
Pagina 4 di 8